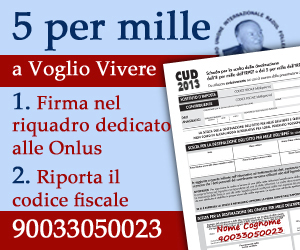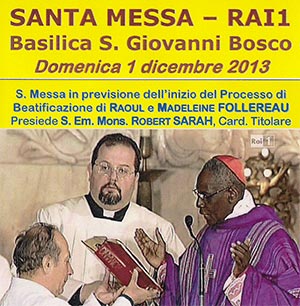di Maria Torelli e Debora Moliterno, volontarie del Servizio Civile Universale – Progetto Italia: “Costruendo ponti: integrazione scolastica per minori migranti” presso Solidarietà e Cooperazione CIPSI.
Nel complesso mosaico geopolitico mondiale, i conflitti rappresentano una realtà persistente e complessa. Dalla guerra civile in Siria alle tensioni tra potenze globali, passando per le dispute territoriali in Asia e le crisi umanitarie in Africa, il mondo è teatro di una varietà di conflitti che affliggono milioni di persone. Questi scontri non solo mettono a dura prova la stabilità delle nazioni coinvolte, ma hanno anche ripercussioni a livello globale, influenzando l’economia, la sicurezza e le relazioni internazionali. La violenza è aumentata di gran misura rispetto agli anni passati. Ad oggi si contano almeno 56 conflitti in 92 Paesi del mondo. L’Ucraina e la Palestina sono considerate i principali focolai di conflitto internazionale ma non dobbiamo dimenticare che ci sono molte altre regioni del mondo in cui sono presenti dei conflitti o considerate vulnerabili alle rivolte. In questa lista figurano: il Messico e la Colombia nelle Americhe; il Pakistan e il Myanmar in Asia; il Sudan, il Sahel e la regione dei Grandi Laghi in Africa: l’Iran, Israele, la Palestina (Gaza), la Cisgiordania e il Libano in Medio Oriente. Di fatto, le Nazioni Unite stimano che nel 2025 circa 305 milioni di persone avranno bisogno di assistenza umanitaria.
In questo articolo, in particolare, analizzeremo un conflitto di cui si parla poco e che ha radici molto profonde, ovvero la guerra della Repubblica Democratica del Congo (RDC), cercando di ripercorrere la storia più recente del Paese, le cause che hanno scatenato il conflitto e le conseguenze che ne derivano.
[1]Vittima del cosiddetto Scramble for Africa, la RDC agli inizi nel ‘900 fu annessa al Belgio. Nonostante inizialmente il governo belga abbia portato condizioni di vita migliori, non si pose mai fine allo sfruttamento economico del territorio. Nel corso del secolo anche nei paesi vicini, di dominazione francese, nacquero movimenti guidati da un forte sentimento nazionalista e indipendentista in opposizione all’impero coloniale. Sotto questa spinta nel 1960, anno importante per molti territori dell’Africa, il governo belga concesse l’indipendenza formale all’ex colonia, convocando le elezioni nel maggio dello stesso anno. Da questo momento in poi la situazione politica del paese, dopo l’elezione di Lumumba, diventò sempre più critica. Sentimenti nazionalisti e visioni panafricaniste, il rapporto con i paesi occidentali e la storia dei paesi vicini come il Ruanda e l’Uganda si intrecciarono con la nascita di un nuovo Paese indipendente che cercava di affermare la propria identità. L’atroce genocidio del Ruanda, evento sensibile nella storia della RDC, provocò l’emigrazione di molti ruandesi tutsi nel paese confinate, sollevando l’indignazione dei gruppi nazionalisti. Dal 1965 si instaurò una dittatura con a capo Mobutu, che cambiò il nome in Zaire e che durò fino al 1997 quando l’organizzazione di un movimento di ribellione nei confronti del regime portò alla fine della dittatura più duratura della storia del Congo belga e alla nascita della Repubblica Democratica del Congo con l’elezione di Laurent-Désiré Kabila.
Tuttavia, questo non portò pace nel territorio, difatti i conflitti interni tra immigrati ruandesi e nazionalisti congolesi continuarono, nonostante gli interventi dell’Onu e la firma di diversi accordi. Con l’assassinio, avvenuto in condizioni misteriose, di Kabila nel 2001, si è cercato di porre fine alla situazione critica che ha caratterizzato gran parte del ‘900 congolese. Nel 2003, con la nascita di un governo provvisorio nel quale confluirono le forze ribelli e gli esponenti vicini alla figura di Joseph Kabila, figlio del precedente presidente, la situazione sembrò stabilizzarsi. Tra luglio e ottobre 2006, le prime elezioni democratiche dal 1960 lo hanno confermato alla carica di presidente,[2]f no al 2019, quando venne eletto l’attuale presidente Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi.

Il conflitto nella RDC si inserisce nel contesto più ampio della crisi della Regione dei Grandi Laghi, situata al centro dell’Africa. In quest’area operano diversi gruppi ribelli, più o meno attivi. Il principale tra essi è il Movimento 23 Marzo (M23), composto principalmente da tutsi congolesi legati ai tutsi ruandesi, e che prende il nome dall’accordo di pace del 23 marzo 2009. Le azioni ribelli nascono proprio per il mancato rispetto di tale accordo da parte del governo congolese. Dopo una lunga pausa, l’M23 ha ripreso le ostilità nel 2021, intensificando gli attacchi nel 2024 contro l’esercito della RDC. [3] L’ultima offensiva risale al 27 Gennaio 2025, quando i ribelli hanno attaccato nuovamente la città. In pochi giorni, l’esercito congolese si è ritirato, mentre i caschi blu, incapaci di fermare i ribelli, hanno perso una decina di soldati.
Le guerre che hanno sconvolto la RDC dagli anni ’90 hanno sempre avuto due comuni denominatori: il possesso delle risorse e le motivazioni etniche [4].
Le ricchezze minerarie del Nord Kivu (RDC), tra cui uranio, oro, diamanti e soprattutto coltan, vengono saccheggiate dalle milizie interne di Nkunda e Mai-Mai[5]. Il coltan è un minerale, presente in grandi quantità nel territorio congolese, fondamentale per la produzione di componenti elettronici ad alta tecnologia, come quelli utilizzati in telefoni cellulari, computer portatili, tablet e dispositivi aeronautici. Questo viene estratto illegalmente e poi trasportato in Ruanda, da dove viene esportato verso i mercati internazionali, spesso attraverso canali non ufficiali. Il commercio di coltan ha un giro d’affari del valore di milioni di dollari, ma contribuisce anche al conflitto armato nella regione, alimentando violenze e instabilità. Le condizioni di lavoro per gli estrattori di coltan sono spesso estremamente precarie, e l’industria ha suscitato preoccupazioni per i diritti umani e l’impatto ambientale. La domanda globale di coltan, legata alla crescente produzione di dispositivi elettronici, continua a stimolare il conflitto per il controllo di queste risorse.
In quanto alle motivazioni etniche, i Tutsi di Nkunda, supportati dal Ruanda, chiedono una revisione dei contratti minerari e la creazione di uno stato federale che destini il 60% delle ricchezze al Nord Kivu. I congolesi ruandofoni, che rappresentano meno del 5% della popolazione, sono principalmente concentrati nelle province del Kivu. Nonostante la loro esiguità numerica, i Tutsi hanno avuto un ruolo politico significativo, grazie al supporto del Ruanda, che giustifica le sue azioni nella RDC come una difesa contro le minacce degli Hutu, nonostante queste siano ora marginali. Recentemente, il Ruanda è stato accusato di “eccesso di legittima difesa”, con l’obiettivo di occupare parte del territorio congolese per far fronte alla sovrappopolazione. Nel contesto del conflitto, il gruppo armato M23 ha intensificato le sue operazioni nel Kivu, creando ulteriori tensioni e instabilità. L’intervento di queste milizie ha complicato la già difficile situazione, con un governo di Kabila che, oltre alla crisi economica (dove il 75% della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno), deve fronteggiare la minaccia dei gruppi armati e la rivalità tra le etnie.
La RDC, per la sua enorme ricchezza di risorse naturali, ha sempre attirato avidità e interessi internazionali[6]. Di fatto, sullo sfondo di tali scontri si muovono tre grandi potenze: gli Stati Uniti, la Francia e la Cina. In questa situazione, i paesi africani hanno cercato di proporre una mediazione. Il Kenya ha tentato, finora invano, di riunire allo stesso tavolo il presidente del Ruanda Paul Kagame e il presidente congolese Félix Tshisekedi, mentre l’Angola ha gestito diverse trattative, anche in questo caso senza successo.
In conclusione, il conflitto che attanaglia la RDC continua a rappresentare una tragedia umanitaria di dimensioni enormi. Nonostante gli sforzi delle organizzazioni internazionali, la situazione rimane estremamente complessa, con possibilità di estendersi con un costo umano drammatico[7]. È fondamentale un impegno più deciso e urgente per prevenire ulteriori sofferenze e stabilizzare la regione e sfidante.
[1] Immagine Istituto per gli studi di politica internazionale, Il conflitto nell’est della RDC, ISPI Online, febbraio 2024.
[2] Sestili T., Storia del Congo- Uno Stato ostaggio dei conflitti interetnici, Il continente misconosciuto- l’Africa geografica e politica oltre gli stereotipi, Policlic, 12 Giungo 2021, pp 16-24.
[3] Fabbi M., Lo scenario critico della Repubblica Democratica del Congo, Affari internazionali, 29 Febbraio 2024.
Internet:https://www.affarinternazionali.it/lo-scenario-critico-della-repubblica-democratica-del-congo/
[4] Bellocchio D., Repubblica democratica del Congo, la guerra che sta contagiando l’Africa, Osservatorio Diritti, 25 Febbraio 2024.
Internet: https://www.osservatoriodiritti.it/2025/02/25/repubblica-democratica-del-congo-guerra/).
[5] Camera. It., La crisi della Repubblica Democratica del Congo.
[6] Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo, Repubblica Democratica del Congo, 9 Gennaio 2023.
Internet: https://www.atlanteguerre.it/conflict/repubblica-democratica-del-congo/
[7] Haski P., Cosa sta succedendo nella Repubblica Democratica del Congo, Internazionale, 28 Gennaio 2025.
Internet: https://www.internazionale.it/opinione/pierre-haski/2025/01/28/repubblica-democratica-cong-ruanda-guerra
L’articolo La Guerra civile nella Repubblica Democratica del Congo sembra essere il primo su Solidarietà e Cooperazione CIPSI.