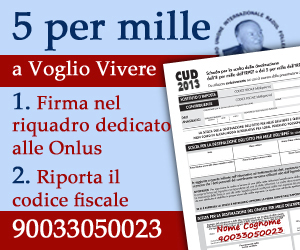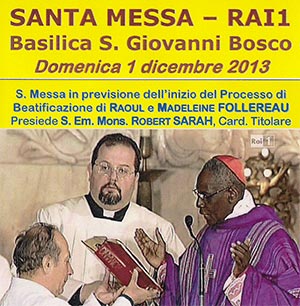di Edoardo Rizzo
Fa un certo effetto essere accolti in lingua quechua piuttosto che in lingua spagnola. La nostra mente si concentra al massimo nel tentativo di capire, come se per questo sforzo destinato comunque al fallimento potesse pur esserci una ricompensa, come se da quelle parole incomprensibili potessimo cogliere un senso che tutto sommato intuiamo, quello di un caloroso benvenuto in terra boliviana per noi ospiti friulani. Questo saluto ci testimonia che le culture native hanno resistito e continuano a resistere alla violenza coloniale, per lo meno qui, facendoci tirare momentaneamente un sospiro di sollievo. Rispondiamo al saluto in quechua in lingua friulana, ma ci chiediamo se anche noi, a parti invertite, avremmo salutato inizialmente in friulano piuttosto che in italiano, come per dire che qui è innanzitutto Friuli, e poi Italia.
La cosa più sorprendente della Bolivia è che formalmente è uno stato plurinazionale, dove le culture che lo compongono e le lingue che vengono parlate sono riconosciute come parte integrante dello stato. Non come folkloristiche minoranze da preservare per fini turistici o strane eccezioni da riconoscere con un certo fastidio.
Più di cinquecento anni fa l’arrivo degli spagnoli determinò la Colonizzazione con tutte le sue violenze. Solo venticinque anni fa altri conquistadores tentarono di prendere per sé ciò che loro non era. E ciò che il popolo di Cochabamba decise che loro non poteva essere. La privatizzazione dell’acqua da parte di una cordata di multinazionali alla fine fallì, ma solo perché la popolazione si oppose con forza, si sollevò e resistette a quel tentativo neocolonialista.
Da quell’esperienza nacque la Fundación Abril, che oggi ci accoglie per commemorare i 25 anni di questa Guerra del Agua che tanto fu di ispirazione per altri movimenti internazionali per il diritto all’acqua, come quello che portò al referendum con il quale, nel 2011, si disse di no alla privatizzazione dell’acqua in Italia.
Pensare globale, agire locale, cooperare
“L’acqua, nella cosmovisione andina, è un ser vivo, un essere vivente. Più che un soggetto di diritto, più che un bene comune. Quasi che, per utilizzarla, dovessimo chiedere il suo permesso”, così Nelly nel presentarci gli assi di lavoro della Fundación. E poi, ancora, “la agricultura natural soberana, o agroecologia, radicata nelle pratiche agricole ancestrali e nell’agricoltura familiare contadina”, e, infine, “il recupero della memoria storica e la ricostruzione del tessuto sociale e organizzativo, sia per quanto riguarda la memoria storica della guerra dell’acqua, sia per quanto riguarda i saperi ancestrali contadini”. Come se il sapere fosse da ricercare non solo nel futuro, quanto anche nella memoria di ciò che si perde.
Qui, ci dice sempre Nelly, la popolazione contadina, quella che tipicamente non parla spagnolo o che comunque parla lingue native, viene stigmatizzata nel segno dell’arretratezza. Un fenomeno che conosciamo anche noi qui in Friuli, dove ancora oggi c’è chi relega la lingua friulana a un ambiente contadino, familiare, privato. Come se Pasolini fosse morto invano.
Oscar, storico leader della Guerra dell’acqua e della Fundación, ci fa invece una panoramica sui problemi attuali della Bolivia. Ai crescenti problemi economici e politici, si aggiunge la frammentazione della società civile, quella che nel nostro ingenuo immaginario occidentale rimaneva una caratteristica forte per lo meno da questa parte del mondo. Per questo, continua Oscar, c’è bisogno di lavorare per ricostruire le comunità, contagiando di allegria e speranza non solo le giovani generazioni, ma innanzitutto noi stessi.
Miguel, invece, ci parla dei problemi ambientali. Degli incendi causati per la deforestazione dell’Amazzonia: la Bolivia, ci dice, è il terzo stato dopo Brasile e Congo che deforesta di più. Dell’importazione di mercurio che serve per l’estrazione dell’oro dalle miniere, con il conseguente inquinamento pesante dei fiumi amazzonici dove vivono un gran numero di popolazioni native che da questi fiumi traggono il loro nutrimento, anche spirituale: le attività di estrazione avvelenano il pesce, ma forse anche l’anima delle persone che qui trovano la loro dimora. Dei problemi, questi, in uno stato che nella sua costituzione afferma tra i principi fondamentali quello di difesa della Pachamama, la madre terra. Un’ipocrisia simile, per certi versi, a quella dello stato italiano rispetto alla questione dell’esportazione di armi.
Comunità, lingue, culture materiali, beni comuni
E poi altre voci, quella di Sonia e quella di Mauri, ci parlano del problema delle sementi transgeniche, dell’incentivo alla produzione familiare e all’autoconsumo, dell’invito a “volver al campo a producir”.
Insieme agli altopiani centrali del Messico, qui si sviluppò originariamente la cultura del mais, in quechua sara, dal quale con un processo di fermentazione si produce la bebida sagrada, la chicha, consumata in un vero rito comunitario dove non si dimentica di dare da bere inizialmente a quella stessa terra madre che, con l’aiuto dell’acqua, il mais lo ha prodotto. Il mais sostentò fra le altre civiltà come quella incaica, maya e mexico-azteca, per essere poi portato in Europa per sfamare la povera gente del vecchio continente, insieme al fagiolo e alla patata. Come qui in Friuli.
È bello pensare alle attività di cooperazione internazionale qui in Bolivia come a un tentativo tardivo di riconoscere questo debito, cercando anche timidamente di chiedere perdono.
Ci ispira ricordare questa Guerra del Agua che fu quella di Cochabamba e che poi, in un certo senso, fu anche la nostra. Per le prossime battaglie che arriveranno, in Europa, in Italia, ma anche in regione. Lo spettro del “gestore unico” si aggira, infatti, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con tutti i rischi del caso.
La presenza di Nelly Perez e Oscar Olivera nel nostro Friuli lo scorso giovedì 8 maggio, nella cornice del festival Vicino/Lontano, ci ha permesso di ascoltare nuovamente le loro voci e vedere i loro visi, per ricordare di non perdere mai, secondo le parole di Oscar, la capacità di indignarci di fronte all’ingiustizia, del passato come del presente.
Per maggiori informazioni: CeVI, tel. 0432/548886 – email: info@cevi.ngo
L’articolo “Aghe e blave. Voci da Cochabamba” sembra essere il primo su Solidarietà e Cooperazione CIPSI.