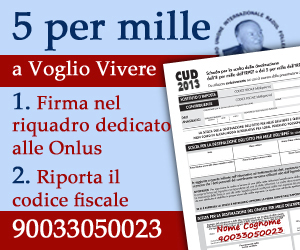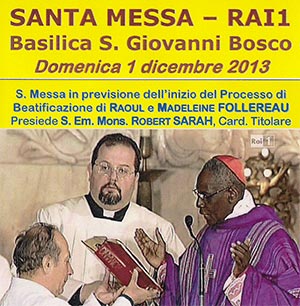di Maddalena Pezzotti
Contesto storico e protagonisti
Quando venne firmato il trattato di Waitangi – te titiri o Waitangi in lingua māori -, le isole neozelandesi erano oggetto del temerario piano di colonizzazione della Compagnia della Nuova Zelanda, fondata a Londra nel 1825. Questa era conformata da aristocratici, latifondisti, uomini d’affari, commercianti, banchieri, assicuratori navali, parlamentari, e un importante editore del tempo, i cui membri fecero un uso aggressivo e sostenuto di connessioni politiche per conseguire i propri fini. Si pretendeva fondare un nuovo modello di società nell’emisfero sud, che avrebbe attratto capitali e generato guadagni, per il quale vennero lanciate campagne pubblicitarie spesso fraudolente.
Le prime esplorazioni e l’espansione coloniale
La prima missione di esplorazione avvenne fra il 1826 e il 1827 e, per il 1853, erano stati impiantati 15.500 coloni. La Compagnia della Nuova Zelanda si considerava alla stregua di un futuro governo e, avendo acquisito milioni di ettari, pur con contratti questionabili, nel 1845, addirittura propose una divisione territoriale, che avrebbe gettato le fondamenta di una provincia indipendente, ma il ministro delle colonie britanniche la rigettò. La Compagnia, sin dagli inizi, e per il corso della sua attività, venne osteggiata dall’ufficio coloniale e dalla società missionaria ecclesiastica, così come da gruppi parlamentari, preoccupati dell’influenza crescente dei suoi fondatori e finanziatori, e della nascita di una dinastia locale svincolata dalla vigilanza centrale.
Le idee di Edward Gibbon Wakefield e il suo piano di colonizzazione
Il progetto si ancorò nelle idee di Edward Gibbon Wakefield, il quale a conclusione di una condanna di treanni di reclusione, per il rapimento di un’ereditiera quindicenne, nel 1829, aveva pubblicato opuscoli e articoli giornalistici, poi raccolti in un libro, promuovendo l’idea di un’emigrazione sistematica verso l’Australasia, attraverso un’operazione sostenuta dallo stato, per aiutare individui e famiglie a uscire dall’indigenza. Lo scopo, in realtà, era di comprare a basso costo, od occupare terre dei residenti indigeni, per rivenderle a un prezzo più alto a gentiluomini inglesi, che ne avrebbero sfruttato le risorse, con l’ausilio dei poveri esportati dal Regno Unito, i quali avrebbero collaborato, allettati dalla prospettiva di accedere a loro volta ad appezzamenti in un certo numero di anni.
La spedizione di Wakefield e le promesse ai Māori
Nel 1839, Wakefield partì per una spedizione, priva dell’approvazione del governo britannico, che aveva il compito di rastrellare proprietà, informando gli abitanti ancestrali che, in ultima istanza, gli sarebbe stato destinato il 10 per cento del territorio, dal momento che, dopo l’installazione dei coloni inglesi, questa porzione sarebbe stata quotata sul piano internazionale a un valore maggiore dell’estensione iniziale che, in pratica, gli veniva sottratta. Wakefield doveva, anche, comunicare che non sarebbero state create riserve come negli Stati Uniti d’America, o instaurato l’obbligo di abbandonare i costumi tradizionali, e che i luoghi di residenza māori sarebbero stati inframmezzati a quelli dei coloni, con un sistema di assegnazione per lotteria, in modo da evitarne l’isolamento.
L’accordo di Waitangi e le sue conseguenze
Il 29 aprile, però, la Corona, con i servizi dell’ufficio coloniale, nella persona del neo eletto governatore William Hobson, concluse l’accordo siglato a Waitangi, che gli procacciava diritti sui terreni messi in vendita, sebbene venne osteggiato da Wakefield, in rappresentanza della Compagnia della Nuova Zelanda, tramite la sua influenza su una buona quantità di capi māori. Nel 1940, venne promulgata una legge che istituiva una commissione incaricata di verificare le condizioni in base alle quali avevano avuto luogo le transazioni della Compagnia, dal momento che capi māori avevano segnalato, in alcuni casi, di non aver acconsentito alle cessioni; in altri, di essere stati tratti in inganno; o di non aver compreso i termini legali. D’altra parte, la norma stabiliva, che i māori sarebbero stati considerati padroni solo della terra occupata dai propri insediamenti comunitari e dalle coltivazioni. Il resto era da ritenersi pertinenza della Corona.
Reazioni degli investitori e concessioni alla Compagnia
Tali disposizioni provocarono il panico fra gli investitori, e quanti avevano iniziato produzioni e commerci, grazie al possesso di titoli, conseguiti con l’intermediazione della Compagnia della Nuova Zelanda. Di conseguenza, furono confermati contratti per 110 mila acri e venne concesso alla Compagnia di esercitare per un periodo massimo di altri quaranta anni. Vennero, inoltre, ottenute compensazioni per i capitali impiegati nel programma di emigrazione dal Regno Unito e l’attività di colonizzazione che aveva favorito l’ingresso dello stato nelle isole.
Firmatari e versioni
Il trattato di Watangi afferma che i māori sono i primi occupanti di Aotearoa, rinominata Nuova Zelanda dai colonizzatori britannici, e sancisce l’accordo fra i rangatira, capi tribù, e la corona inglese, rappresentata da Hobson. Il trattato venne siglato nella sua versione nella lingua māori da una vasta maggioranza dei rangatira, oltre cinquecento. Nella versione in lingua inglese, tradotta dai missionari Henry e Edward Williams, padre e figlio, tuttavia, sono riportate solo trentanove firme. Il trattato venne contestato dai māori a solo meno di un anno, in quanto fra le due versioni, sono presenti divergenze significative nella traduzione dei termini strategici sovereignty, kāwanatanga e te tino rangatiratanga.
La strategia britannica e il ruolo dei traduttori
Il testo venne redatto da consiglieri di stato che sapevano cosa facevano, in merito alla proprietà della terra e l’insediamento di coloni, ed erano guidati dall’esperienza di altri negoziati. Dal canto loro, i traduttori non erano degli sprovveduti, e con probabilità ricevettero istruzioni di fare uso di ogni mezzo possibile per convincere i rangatira a sottoscrivere il documento. Come se non bastasse, nella mentalità coloniale, “i selvaggi” erano, senza dubbio, meglio tutelati sotto l’egida inglese. Secondo gli esperti, la parola sovereignty – posizione suprema nei processi decisionali di uno stato -, non ha una traduzione diretta in māori, perché i capi tribù, pur esercitando autorità nelle proprie aree, non erano soggetti a una sovrastruttura centrale. Per i māori, dunque, cedere la sovranità era un concetto culturalmente incomprensibile. Peraltro, i māori avevano in uso la parola kawanatanga, una translitterazione del termine governance – azione di gestire uno stato -. Quindi, mentre i britannici intendevano stabilire un ordine di controllo assoluto, comprensivo di popolo, territorio e sovranità, i māori, nel loro vocabolario, avevano accettato solo una forma di amministrazione parallela, intesa a disciplinare le attività negli insediamenti dei coloni dove, all’epoca, vigeva uno stato di semi anarchia, in cambio della promessa di protezione militare, nell’interesse del mantenimento della pace e dell’ordine, in tempi in cui la Francia aveva dimostrato mire di conquista. Non vi è ombra di dubbio che i capi fossero coscienti di stare concedendo spazi di potere, ma l’uso dei termini kāwanatanga e te tino rangatiratanga, nella versione māori, indica con chiarezza che la loro intenzione era di instaurare un partenariato con la Corona inglese, e non una situazione di assoggettamento. E ancora, sebbene nel testo inglese, ai māori venga garantito il possesso totale e indisturbato delle zone abitate, lavorate, e dedicate al culto, delle riserve di caccia e pesca, e di altre risorse, in tale versione, i māori concedono alla Corona il diritto esclusivo di acquisto delle loro terre, se e quando intenzionati a venderle. In quella in lingua locale, invece, gli stessi attribuiscono alla Corona solo un diritto di prelazione su altri concorrenti.
Un trattato fondante per l’identità māori
Nondimeno, nell’epilogo, entrambe le parti, convengono di accettare lo “spirito” del trattato e, per buona sorte, questo è ciò che conta di più. Infatti, secondo il tribunale Waitangi, organo istituito nel 1975, deputato a dirimere dispute sorte dalla violazione del trattato, e stabilire la corretta interpretazione fra i due testi, ha ribadito che lo stesso è da considerarsi uno strumento, diplomatico e politico, di massima per la formazione di uno stato nazione, dove i diversi interessi devono trovare spazio. Per i māori il trattato è, pertanto, il caposaldo giuridico del riconoscimento come popolo, e della direzione inclusiva in cui la Nuova Zelanda deve continuare a procedere. Per questa ragione, alcuni mesi fa, una hikoi (marcia di pace) di nove giorni, ha sottolineato il rifiuto dei māori per un disegno di legge che intendeva reinterpretare il trattato di Waitangi e ridurne l’importanza. Anche il tribunale Waitangi ha dichiarato che avrebbe eroso sfere di diritti, in quanto non considera la discriminazione strutturale a cui i māori sono stati soggetti nella storia del paese, le confische avvenute dal 1877, quando il governo dichiarò nullo il trattato, e gli effetti generazionali delle gravi violazioni accadute dal 1959 al 2019, attribuite allo stato e della chiesa, per le quali il primo ministro Christopher Luxon ha rilasciato scuse istituzionali. I leader māori hanno definito “disonorevole” per lo stato voler rescindere dallo spirito del trattato.
Situazione attuale: tensioni politiche e sociali
Secondo il censimento del 2023, su una popolazione di 5.3 milioni, i māori sono 978,246, intorno al 19 per cento. Sono rappresentati dal Te pati māori, un partito che detiene 6 dei 123 seggi in parlamento. Sebbene il progetto di legge sia fallito, l’attuale coalizione conservatrice ha rimosso una norma che dava ai māori la possibilità di indirizzare le politiche ambientali e, lo scorso febbraio, ha abolito l’autorità pubblica per la salute māori, in questo modo, incendiando un dibattito che divide la società.
Malgrado le insidie della traduzione, e la discontinuità dell’applicazione, con il Trattato di Waitangi, i māori, da una prospettiva storica, assicurarono un consenso sul mantenimento con autodeterminazione di territorio vitale, l’attribuzione degli stessi diritti dei cittadini del Regno Unito, e una concezione di nazione multietnica per la nascente Nuova Zelanda- Aotearoa. Tutto ciò in un periodo in cui l’espansionismo geopolitico delle potenze europee minacciava la sopravvivenza dei popoli indigeni.
L’articolo Il trattato di Waitangi sembra essere il primo su Solidarietà e Cooperazione CIPSI.